Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Moderatori: MrMassy86, adobel55, lorelay49, Docdelburg
-
aleroma
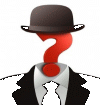
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Fino a poco tempo fa avevo un “plastirama” se così vogliamo chiamarlo, dove mi divertivo con i miei modelli, ma attualmente cambiando casa mi ritrovo senza neanche un binario dove far girare i miei treni.
Sono riuscito però a trovare lo spazio e farò alcuni lavori nella nuova casa, così da recuperare una stanza di una decina di metri quadri per un plastico in scala 1/87, che sarà ambientato in centro Italia e servito da una piccola ferrovia privata.
Nell'attesa del plastico e di aprire gli scatoloni del trasloco, volevo presentarvi il progetto della ferrovia “freelance” che sto portando avanti ormai da un bel po’, seguendo la realtà di alcune ferrovie concesse in Italia, vi voglio far leggere quindi, una specie di racconto che sto scrivendo e che metterò davanti al plastico e che spiegherà la storia della mia freelance e del plastico stesso.
Naturalmente vi mostrerò anche le foto appena posso.
Spero che la cosa vi interessi (che non vi annoi) e che magari possiate anche darmi qualche buon consiglio.
Alessio
-
aleroma
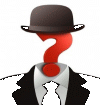
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Tra storia e fantasia, nasce e vive tutt’ora il Gruppo FAI, società che gestisce una ferrovia freelance in scala 1/87, ambienta nel centro Italia. Per rendere la storia di questa ferrovia credibile, mi sono divertito a mescolare fatti storici realmente accaduti con fatti storici decisamente inventati, che ben miscelati creano vita alla società stessa, una vita simile a tante ferrovie concesse che realmente sono esistite e che esistono ancora oggi.
Ispirato dalla reale storia delle SV e le sue molte linee, da varie ferrovie in concessione in Italia e dalla chiusura di tratti ferroviari delle ferrovie dello stato, ho voluto creare un filo logico tra storia e finzione che solamente uno storico e un appassionato potrà scorgere la linea che divide l’immaginazione dalla realtà.
Quando il plastico sarà terminato questo racconto una volta rilegato verrà posto davanti al plastico stesso.
Il Gruppo Fai in breve:
La Società Ferroviaria Appennino Italia nasce all’inizio del XX secolo, rilevando dalle SV, la gestione della linea Borgonaccio Terme – Montemomi.
La linea aperta e gestita infatti dalla SV dalla fine del XIX secolo, passa in subconcessione nel 1907 alla FAI (controllata da SV) fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, durante gli anni del conflitto la linea fu chiusa al servizio regolare ad adibito al trasporto militare. Nella ricostruzione post bellica l’intera tratta molto danneggiata dalla ritirata dell’esercito tedesco, verrà ripristinata e mantenuta in gestione sempre dalla FAI (di fatto non più una controllata SV) che rimarrà concessionaria fino ai giorni nostri, subentrando al posto delle SV che lasciarono la concessione originaria, quando dopo la guerra, si ritrovò a cedere o sopprimere molte linee per questioni economiche.
Tra gli anni ‘60 e ‘80 la FAI ebbe un periodo fortunato, (in controtendenza rispetto ad altre ferrovie in concessione) quando oltre al locale servizio passeggeri, iniziò una discreta attività nel trasporto merci, anche grazie alle numerose aziende e consorzi agrari che furono costruiti vicino la linea.
Nel 2007 grazie all’acquisizione dell’ormai abbandonata linea Civitavecchia-Capranica–Orte, da parte della regione Lazio, la FAI nel 2010, riuscì ad arrivare al mare prendendo la gestione della tratta, dopo averla grazie ai fondi europei, regionali e privati, ripristinata ed elettrificata.
Fu per la società una grande occasione in quanto nonostante le spese necessarie per il ripristino delle tratte in questione, portò nelle casse un attivo di bilancio grazie al cospicuo introito dato dal trasporto merci, tanto che la FAI cambiò ragione sociale proprio dopo l’acquisizione del tratto fino ad Orte, infatti divenne Gruppo FAI, dove all’interno del gruppo furono create tre divisioni: Regio FAI – FAI Cargo&Logistics – Green FAI.
Quasi in contemporanea il Gruppo FAI, che era in maggioranza di proprietà della regione e del consorzio formato dai comuni interessati dalla linea (consorzio creatosi dopo l’abbandono di SV), subisce un cambio di proprietà, la maggioranza infatti passa a società private che hanno interesse al trasporto di vari tipi di merce, mentre la minoranza della proprietà rimane ai comuni e alla regione che avranno meno spese da sostenere, quindi, grazie all’entrata di nuovi fondi privati, le tre divisioni FAI nate nel 2011, cominciarono ad acquistare altro materiale rotabile, prendendolo sia di seconda mano da ferrovie estere, che completamente nuovo, ordinandolo per le esigenze delle proprie linee.
A Regio FAI è assegnato il compito di gestire il trasporto regionale, anche su gomma per raggiungere i paesi non serviti dal treno, che su ferro creando collegamenti diretti fino a Roma.
A FAI C/L è assegnato il compito di gestire il trasporto merci: su gomma, garantendo il trasporto delle merci anche in luoghi dove la ferrovia non è presente, per arrivare a servire anche i piccoli centri e le aziende clienti; su ferro nelle proprie linee, e transitando in regime di concorrenza su rete RFI.
Dal 2015 la divisione Cargo ha assunto un carattere internazionale varcando i confini per collegamenti con il nord e l’est Europa, ma con l’obiettivo di estendersi ancora, la divisione Cargo ha iniziato una partnership con una delle società proprietarie, una multinazionale americana che produce vetro cavo, garantendo il trasporto dai porti di Civitavecchia, Gaeta e Falconara, di materiale necessario per gli stabilimenti produttivi sparsi per l’Italia, e per la distribuzione del prodotto finito.
A GreenFAI invece è affidato il compito delle infrastrutture, manutenzione e al neonato servizio turistico, infatti vista la bellezza delle linee e delle località termali che queste servono, sono nati i collegamenti turistici che spesso vengono affidati a treni di carattere storico nel periodo estivo, e alle carrozze belvedere nel periodo invernale.
Nel 2016 altri due eventi strategici per la FAI portano nuovi treni sulle linee, le ferrovie dello stato, tramite RFI, entrano a far parte del gruppo di società che controllano FAI, viene poi firmato un accordo tra vari tour operator stranieri e italiani, per l’organizzazione di treni turistici.
Nel 2017 il gruppo FAI sigla un altro accordo, con il Fai (fondo ambiente italiano) per l’organizzazione di treni storici e viaggi turistici verso le mete scelte dal Fondo Ambiente. L’accordo è stato battezzato col nome di FAI&FAI.
to be continued...
-
marione

- Messaggi: 2359
- Iscritto il: lunedì 4 marzo 2013, 13:41
- Nome: Mario
- Regione: Lombardia
- Città: treviglio
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Bravo
Ciao
Marione
-
aleroma
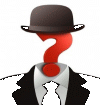
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
-
MrMassy86

- Socio GAS TT
- Messaggi: 15770
- Iscritto il: sabato 10 novembre 2012, 15:42
- Nome: Massimiliano
- Regione: Toscana
- Città: Capannori
- Ruolo: Moderatore
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Massimiliano
-
aleroma
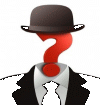
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Rispetto al disegno che vedete qui, ho deciso di fare alcune modifiche anche al paesaggio, infatti ci saranno due centri abitati, uno sopra la curva dopo il ponte che scavalca la linea a doppio binario (per coprire la curva stretta) e l'altro al posto della fattoria che si vede in mezzo al curvone a binario singolo prima del ponte (anche in questo caso il curvone sarà in parte coperto).
Il tracciato non altro che un osso di cane rigirato su se stesso con due grandi stazioni nascoste con la possibilità di ospitare circa 15 convogli, un tratto a binario singolo collegato, che porta alla stazione terminale di Civita di Borgonaccio terme, stazione a cui fa capo la Freelance, naturalmente anche le FS effettuano servizio sul plastico. L'ambientazione in senso temporale spazia molto, ovvero dagli inizi del 1907 fino ad arrivare a circa vent'anni fa, non tenendo in considerazione il periodo attuale. L'impianto sarà interamente digitale per evitare km di fili per i sezionamenti.
Alessio
-
Egidio
- Messaggi: 14288
- Iscritto il: giovedì 17 maggio 2012, 13:26
- Nome: Egidio
- Regione: Abruzzo
- Città: Ortona
- Stato: Non connesso
-
adobel55

- Socio GAS TT
- Messaggi: 11434
- Iscritto il: venerdì 18 novembre 2011, 15:51
- Nome: Adolfo
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Ruolo: Moderatore
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Da seguire con attenzione e interesse.
Ciao
-
Egidio
- Messaggi: 14288
- Iscritto il: giovedì 17 maggio 2012, 13:26
- Nome: Egidio
- Regione: Abruzzo
- Città: Ortona
- Stato: Non connesso
-
MrMassy86

- Socio GAS TT
- Messaggi: 15770
- Iscritto il: sabato 10 novembre 2012, 15:42
- Nome: Massimiliano
- Regione: Toscana
- Città: Capannori
- Ruolo: Moderatore
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Massimiliano
-
marione

- Messaggi: 2359
- Iscritto il: lunedì 4 marzo 2013, 13:41
- Nome: Mario
- Regione: Lombardia
- Città: treviglio
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Marione
-
aleroma
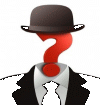
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Capitolo 1
Le origini, dal 1872 al 1889, la storia della SV e nascita della FBM (che sarà poi FAI)
La Società Veneta per le imprese e costruzioni pubbliche fu fondata a Padova l'11 gennaio 1872 da un gruppo di notabili locali tra i quali in seguito spiccò ai vertici aziendali l'ingegnere Vincenzo Stefano Breda. La sua costituzione fu poi approvata dal governo con il regio decreto 25 gennaio 1872.
Nei primi due anni di attività, la Veneta ottenne diversi appalti i quali poi vennero effettivamente realizzati in subappalto da aziende minori come ad esempio la costruzione degli argini sul Po, quella di un ponte sul Piave e quella della sede del Ministero delle Finanze a Roma completata nel 1879. Furono poi effettuati scavi lagunari in provincia di Venezia.
Nel 1876 ottenne i lavori di ampliamento del porto di Genova, mentre tre anni dopo si aggiunsero quelli nei porti di Napoli e di Castellammare di Stabia. In seguito si aggiunsero cantieri presso altri porti, tra i quali quelli di Brindisi, di Barletta e di Palermo, ma l'impresa non riuscì a far fronte finanziariamente ai numerosi impegni tant'è che i soci dovettero versare venti milioni di lire nel 1884 per riequilibrare il patrimonio aziendale.
A fianco delle costruzioni di porti e immobili, nel 1874, la Veneta iniziò ad operare anche nel ramo ferroviario ottenendo in subconcessione l'esercizio sia della ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, in questo caso direttamente dalla provincia di Vicenza in qualità di concessionario originario, sia delle linee Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, queste ultime soprannominate "consorziali" in quanto concesse ad un consorzio comprendente la provincia di Padova, quella di Treviso e quella di Vicenza. A queste ferrovie si aggiunse, nel 1879, la Conegliano-Vittorio Veneto.
Nel corso degli anni ottanta e novanta del XIX secolo, la Veneta incrementò il proprio interesse nel ramo ferroviario tanto che divenne il settore principale di tutta l'attività aziendale, per cui, nel 1898, l'organo volitivo decise quindi di modificare la ragione sociale in Società Veneta per la costruzione e l'esercizio di Ferrovie secondarie italiane. Per diversi anni, tuttavia, l'azienda patavina proseguì anche nell'attività di costruzione di altre opere civili: l'ultima commessa non ferroviaria fu l'ampliamento del porto di Cadice il cui appalto fu ottenuto nel 1907.
Nel quinquennio 1884-88, (secondo il Cornolò 2005) proprio a seguito del riordino finanziario precedentemente citato, la Veneta accrebbe la propria operatività in campo ferroviario e tranviario espandendosi anche al di fuori delle province venete.
Nel Lazio, la SV istituì nel 1884 la Società per la Ferrovia Albano-Anzio-Nettuno (FAAN), nata per esercire la linea omonima, contribuendone alla metà del capitale sociale. La FAAN acquistò anche la concessione della tranvia Portonaccio-Ciampino-Marino e ne affidò l'esercizio alla Società Veneta che la mantenne fino alla chiusura della tranvia stessa, avvenuta dopo che la Società Ferrovie Secondarie Romane (SFR) aprì la Roma-Albano nel 1889.
Negli stessi anni sempre nel Lazio diede vita alla ferrovia Borgonaccio - Montemomi dandola in gestione ad una società controllata dalla stessa Veneta, denominata FBM.
La linea partiva da Montemomi, e serviva molti paesi dell’alto lazio che in quegli anni erano sprovvisti di linee ferroviarie collegando il lago di Bolsena per arrivare nella zona termale di Borgonaccio. Dieci anni dopo venne costruita la Civitavecchia – Orte (FS) che la incrociava vicino il paese di Blera.
All'inizio del 1885, la Veneta ottenne in subconcessione l'esercizio della ferrovia Parma-Suzzara, completata poco più di un anno prima da un consorzio di enti locali istituito appositamente. Il 14 settembre dello stesso anno la controllata Società delle Guidovie Centrali Venete (GCV) aprì la diramazione tranviaria Malcontenta-Mestre seguita, l'11 novembre, dalla linea principale Padova-Malcontenta-Fusina.
Il 20 maggio dell'anno seguente la GCV inaugurò un'altra interurbana in terra veneta, la Padova-Bagnoli di Sopra. Il 20 del mese successivo fu la volta di un'altra tranvia in terra emiliana, la Bologna-Imola, in questo caso esercita direttamente dalla SV. Pochi giorni dopo la Veneta inaugurò una ferrovia, la Udine-Cividale, prima linea sociale in Friuli, mentre il 22 luglio fu aperta all'esercizio la Camposampiero-Montebelluna.
Nel 1887 furono inaugurate le linee ferroviarie della Veneta nel bolognese: la Bologna-Budrio-Portomaggiore e la Budrio-Massalombarda. L'anno seguente, l'impresa ferroviaria proseguì ad espandersi in Friuli con l'apertura della Portogruaro-San Giorgio di Nogaro e della Udine-Palmanova-San Giorgio di Nogaro; in Toscana venne aperta anche la Arezzo-Stia dopo tre anni di lavori.
Nel 1889 la SV assunse anche l'esercizio della Roma-Albano come subconcessionaria della SFR. Due anni dopo, quest'ultima ne riprese la gestione, assieme alla Albano-Nettuno.
continua...
-
aleroma
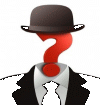
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
-
Egidio
- Messaggi: 14288
- Iscritto il: giovedì 17 maggio 2012, 13:26
- Nome: Egidio
- Regione: Abruzzo
- Città: Ortona
- Stato: Non connesso
-
aleroma
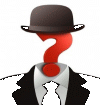
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
A cavallo di due secoli: nuove linee e prime cessioni allo Stato da parte SV
Nel 1896, lo Stato italiano riconobbe alla Veneta la prosecuzione decennale della concessione sulle linee consorziali e sulla Vicenza-Schio.
L'anno dopo fu aperta al traffico la linea San Giorgio di Nogaro-Cervignano presso la quale si innestava a quella proveniente da Monfalcone, costruita dalla Società Ferroviaria Friuliana (FEG) e gestita dalle imperial-regie austriache. Per il gruppo della Veneta essa fu la prima ferrovia a carattere internazionale in quanto varcava il confine tra l'Italia e l'Impero austro-ungarico. La sua apertura consentì inoltre l'istituzione di un percorso più breve e diretto fra Venezia e il porto di Trieste rispetto a quello esistente a quel tempo, passante per Treviso e Udine.
Nel 1902, la Veneta ottenne la sua prima concessione ferroviaria nella provincia di Ferrara e l'anno dopo, il 21 novembre, attivò la linea per Copparo.
Due anni dopo, la SV rilevò da un precedente concessionario la tranvia Udine-San Daniele, a scartamento metrico.
Il 1º luglio 1906 avvenne il passaggio formale delle linee consorziali e della Vicenza-Schio alle Ferrovie dello Stato (FS) e il 1º ottobre, una società controllata dalla Società Veneta, la Ferrovie Nord Vicenza (FNV) assunse l'esercizio delle linee a scartamento ridotto, da 950 mm, situate nella parte settentrionale del vicentino: la Torrebelvicino-Schio, la Schio-Rocchette e la Rocchette-Arsiero. Le linee erano state costruite dalla Società Ferrovie Economiche di Schio (SFES) che non era più in grado di garantire i servizi ferroviari ed era stata posta in liquidazione nel corso dello stesso 1906.
Ancora durante il 1906, iniziarono i lavori per la costruzione della ferrovia Thiene-Rocchette, per la quale fu adottato lo scartamento ordinario come la Vicenza-Thiene-Schio, che fu aperta al traffico il 7 settembre 1907. Nello stesso mese, la Veneta ottenne dalla Società per la ferrovia Alessandria-Ovada (SAO), l'esercizio dell'omonima linea ferroviaria. La linea fu poi riscattata dallo Stato sul finire dell'anno, ma la SV ne mantenne l'esercizio.
Nel 1905 nasce la Società FAI (Ferrovie Appenino Italia) controllata della SV, che avrebbe dovuto gestire altre linee che la Veneta progettava per l’alto Lazio (progetti che però rimasero solo sulla carta), e nel 1907 la prima e l’unica linea a passare sotto la gestione FAI fu la Borgonaccio – Montemomi, che avrebbe dovuto condividere una stazione con la Orte –Capranica – Civitavecchia gestita dalle ferrovie dello stato. Tre anni più tardi in attesa dell’innesto con la rete FS per dare la possibilità ai viaggiatori di arrivare a Roma via Orte o Civitavecchia, la Società FAI commissionò sempre alle SV la costruzione di un nuovo tratto verso nord, raggiungendo così, grazie al bivio presso Spillo di S'Anna, prima di Borgonaccio Terme, altre località dell’alto Lazio, arrivando a Valcigo come ultima stazione, che sui progetti iniziali doveva essere la stazione di collegamento con la linea Valcigo – Arezzo, mai costruita.
Tra il 1908 e il 1910, un'altra impresa controllata dalla Veneta, la Società Italiana per la Ferrovia della Valsugana (SIFV), fu impegnata nella costruzione della Mestre-Bassano-Tezze presso la quale si sarebbe innestata con la linea austro-ungarica proveniente da Trento. Il 15 luglio 1908 fu aperto il tronco Mestre-Bassano del Grappa, a cui fece seguito, il 1º gennaio dell'anno seguente, il tratto Bassano-Valstagna e quindi, il 21 luglio 1910, il Valstagna-Tezze. Primolano divenne stazione internazionale di trasmissione fra la rete ferroviaria austriaca e quella italiana.
Nel corso del 1909, a seguito di regolare riscatto da parte dello Stato italiano, la Camposampiero-Montebelluna passò alle FS. Il 19 maggio dello stesso anno, dopo due anni di lavori, fu avviata la trazione elettrica sulla Padova-Piove di Sacco, primo esempio in tal senso nel gruppo della Veneta. L'azienda adottò un sistema simile a quello in uso sulla ferrovia della Valle Brembana: in corrente alternata con frequenza da 25 hertz e con una tensione di 6 000 volt. Il 28 luglio 1909 fu aperto il primo tratto della Ferrara-Modena, tra il capoluogo ferrarese e Cento.
Oltre al tratto conclusivo della linea della Valsugana, nel 1910 furono aperte al traffico altre due linee. Il 10 febbraio iniziò il servizio sulla Rocchette-Asiago che ebbe la caratteristica di avere un tratto cremagliera per risolvere la differenza altimetrica tra l'altopiano di Asiago rispetto al resto della provincia vicentina; fu costruita dalla SV che la subconcesse alla FNV. Il 9 maggio fu aperta la Carnia-Villa Santina. Nello stesso 1910, la Veneta rilevò la gestione della ferrovia Verona-Caprino-Garda dall'omonima società.
Nel 1910 anche sulla tratta Borgonaccio T. –Montemomi, iniziarono i lavori per adottare il sistema di trazione elettrica a corrente alternata, con frequenza da 25Hz e tensione di 6000V analoga alla Valle Brembana.
Nel 1911, fu aperto il tratto Cento-Decima, della Ferrara-Modena, e la diramazione Decima-San Giovanni in Persiceto.
Per motivi prettamente militari, nel 1912, la Mestre-Primolano-Tezze fu rilevata dallo Stato, passando all'esercizio delle FS. L'anno dopo le stesse ferrovie statali assunsero anche la gestione diretta della Alessandria-Ovada. Sempre nel 1913, fu inaugurata la trazione elettrica sulla Padova-Piove di Sacco, con le medesime caratteristiche applicate sulla Padova-Malcontenta-Fusina.
Poco prima dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale, la Veneta inaugurò un gruppo di tranvie a scartamento metrico in provincia di Treviso: la Montebelluna-Caselle d'Asolo e la Montebelluna-Valdobbiadene furono aperte il 17 agosto 1913, mentre il 16 novembre seguente fu attivata la Susegana-Pieve di Soligo. Il 20 gennaio dell'anno successivo fu ultimato l'itinerario della prima linea fino ad Asolo. Le tranvie facenti capo a Montebelluna furono elettrificate con specifiche diverse da quelle adottate per le linee delle GCV, dato che venne applicato un sistema in corrente continua con tensione a 975 volt; la trazione della linea Susegana-Pieve di Soligo rimase a vapore.
continua...
-
aleroma
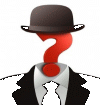
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
ad ogni gruppo di locomotive, ho dato una classificazione seguendo la logica dell'epoca di alcune società ferroviarie, ad esempio locomotive con rodiggio 020 vengono classificate Gr20, le 030, Gr30.
Ma questa è un'altra storia che vi racconterò nei prossimi capitoli.
Buonanotte
-
aleroma
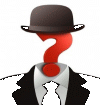
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
-
Egidio
- Messaggi: 14288
- Iscritto il: giovedì 17 maggio 2012, 13:26
- Nome: Egidio
- Regione: Abruzzo
- Città: Ortona
- Stato: Non connesso
-
aleroma
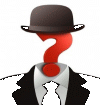
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Il primo dopoguerra
Dopo la battaglia di Vittorio Veneto e l'armistizio di Villa Giusti, la Veneta riprese possesso sia delle linee oltre il Piave sia del materiale rotabile che non era stato trasferito dall'esercito austro-ungarico in località esterne ai confini italiani, materiale che per esigenze fu trasferito su varie linee gestite dalla veneta, alcune locomotive e carrozze arrivarono in questo modo fino a Borgonaccio nel Lazio.
Rapidamente furono riattivate le linee sociali, ad eccezione di alcune la cui gravità dei danni impediva una ripresa immediata dei servizi, come nel caso della Palmanova-San Giorgio di Nogaro e delle tranvie nella provincia di Treviso.
Nel corso degli anni seguenti, il complesso delle linee della Veneta si ridusse per diversi motivi. Le ferrovie a scartamento ridotto da 750 mm passarono a tre diversi concessionari:
la Tolmezzo-Paluzza, privata del tratto fino a Moscardo, dal 1919 fu gestita dalla Società Elettrica di Paluzza e in seguito dal consorzio tranvia del But;
la Villa Santina-Comeglians passò al Consorzio Val Degano nel 1920;
la Cividale-Susida fu concessa all'impresa Eredi Binetti di Cividale nel 1921 che si occupò di costruire un nuovo tratto fino a Caporetto.
Nel 1920, le FS rilevarono l'esercizio di buona parte delle linee friulane della Veneta in quanto ritenute di interesse strategico dallo Stato italiano: la Udine-Palmanova-Cervignano, la Palmanova-San Giorgio di Nogaro e la San Giorgio di Nogaro-Cervignano. La Cervignano-Pontile per Grado era passata alle ferrovie statali già nel 1918.
Nel 1924, la SV perse la gestione sia della tranvia Udine-San Daniele, che passò all'ingegner Giacomo Cantoni, sia della Verona-Caprino-Garda, la quale fu riscattata dalla provincia di Verona.
Secondo il Cornolò (2005), nel 1925 la Veneta fu privata pure dell'esercizio della tranvia Susegana-Pieve di Soligo in quanto acquisita da altra amministrazione. Il 30 novembre dello stesso anno, la FNV, da tempo in difficoltà e da diversi anni in stato di liquidazione, fu costretta a terminare l'esercizio delle sue linee. La Società Veneta subentrò alla sua controllata nei mesi seguenti, riaprendo al contempo tutte le linee, ad eccezione della ferrovia Torrebelvicino-Schio, il 12 settembre dell'anno seguente.
Il 27 maggio 1928 fu attivata la trazione elettrica sulla tranvia Padova-Bagnoli di Sopra che fu l'ultima del gruppo delle Guidovie Centrali Venete a venire elettrificata. L'anno seguente si procedette a spostare il capolinea patavino da Piazza Ermitani alla stazione di Santa Sofia.
Il 31 marzo e il 1º giugno 1931 furono chiuse le tranvie SV facenti capo a Montebelluna, rispettivamente quella per Valdobbiadene e quella per Asolo. Il 28 ottobre fu aperta la Piove di Sacco-Mestre che completò il percorso ferroviario tra Venezia e il Polesine.
Nel 1932 FAI iniziò lo studio per il passaggio in corrente continua a 3000 V della linea Borgonaccio – Montemomi , in conformità con gli impianti FS così da attuare agevoli interscambi con la Civitavecchia – Orte, questo avrebbe migliorato il trasporto merci tra le due amministrazioni, ma le FS decisero di non elettrificare la loro linea. Quindi la decisione di passare in continua per FAI, non fu più presa, e rimase l’elettrificazione in alternata, anche perché il materiale rotabile era sostanzialmente recente e cambiarlo o adattarlo alla continua avrebbe avuto un peso economico non indifferente. Ma l’idea di passare alla continua rimase nel tempo (cosa che poi avvenne qualche anno dopo) anche per motivi di concorrenza con l’allora vicina e appena riammodernata linea Roma –Civita Castellana – Viterbo che nel 1927 decise di passare da tranvia a scartamento ordinario e l'elettrificazione in corrente continua a 3 000 V, sempre in conformità con gli impianti FS per effettuare interscambi con le statali presso Fabrica di Roma.
Nel 1933, fu ultimata la ricostruzione a scartamento ordinario della ferrovia Rocchette-Arsiero, la quale fu l'ultima costruzione ferroviaria effettuata dalla Società Veneta nell'arco della sua attività aziendale.
Due anni dopo, terminò l'esercizio della tranvia Bologna-Imola. Nello stesso periodo, la SV decise di sperimentare la trazione termica sia introducendo bruciatori a gasolio sulle locomotive a vapore sia affidandosi alla costruzione di nuove automotrici. L'anno seguente arrivarono i primi modelli del gruppo ADn 500 che furono introdotti sulla Adria-Mestre e sulla Ferrara-Copparo. Al termine dell'anno fu convocata un'assemblea straordinaria della GCV con il compito di approvarne la liquidazione; le sue tranvie erano già da anni esercite direttamente dalla capogruppo.
Nel 1937, lo Stato italiano riscattò la Conegliano-Vittorio Veneto; le FS si incaricarono di costruire il tronco fino a Ponte nelle Alpi.
Nel 1942, la Veneta ottenne in subconcessione dalla Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie (SVEFT) l'esercizio della ferrovia Adria-Ariano Polesine
continua...
-
aleroma
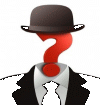
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
-
aleroma
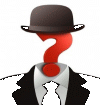
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
-
MrMassy86

- Socio GAS TT
- Messaggi: 15770
- Iscritto il: sabato 10 novembre 2012, 15:42
- Nome: Massimiliano
- Regione: Toscana
- Città: Capannori
- Ruolo: Moderatore
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Mi sto leggendo i vario post con molto interesse e curiosità
Massimiliano
-
aleroma
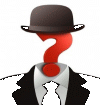
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
continuando con la storia: Il secondo dopoguerra tra ricostruzioni e dismissioni
La maggior parte dei danni alle Venete, dovuti al conflitto bellico si verificarono nel periodo in cui il settentrione italiano fu occupato dall'esercito tedesco e furono provocati da azioni compiute sia dagli occupanti sia dalle forze partigiane e alleate. I servizi ferroviari e tranviari furono pressoché sospesi nell'arco di poco tempo a partire dal settembre 1943.
Nell'estate 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale fece decadere il consiglio d'amministrazione e nominò un commissario, l'ingegnere Leonarduzzi, che si occupò di inventariare la situazione e di procedere al ripristino delle attività. Parecchie linee furono trovate in condizioni pietose, con l'armamento asportato e il materiale rotabile distrutto o sottratto, per cui si procedette alla ricostruzione dando la precedenza a quelle linee che potevano riprendere l'attività in poco tempo. Comunque, nel giro di due anni, tutte le linee sociali vennero riaperte ad eccezione della diramazione San Giovanni in Persiceto-Decima, della Adria-Ariano Polesine e della ferrovia Casentinese. Le prime due perché considerate non ripristinabili per le dimensioni delle distruzioni operate dagli eventi bellici e dall'esercito tedesco in ritirata, la terza in quanto passò ad un'altra società, La Ferroviaria Italiana (LFI), che la sistemò e la riaprì nel 1950
Gli sforzi per la ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie e tranviarie furono notevoli, ma negli anni successivi apparvero sprecati alla luce della politica che la Veneta attuò per ridurre le perdite in bilancio, ovvero quella della soppressione dei servizi ferrotranviari e della loro sostituzione con gli autobus.
Un primo esempio fu la ferrovia Schio-Rocchette che chiuse il 20 giugno 1949. La rete delle interurbane di Padova fu soppressa nel 1954, mentre due anni dopo fu la volta delle ferrovie facenti capo a Ferrara. La Rocchette-Asiago fu chiusa nel 1958.
Già nel 1955, i prodotti derivanti dai servizi automobilistici superarono quelli dei ferroviari.
Anche un’altra linea fu ceduta per ridurre le perdite di bilancio, infatti dopo una lenta ricostruzione dei tratti danneggiati della Borgonaccio – Montemomi e la sua diramazione per Valcigo, nel 1946, le SV cedettero la linea ritenuta allora poco redditizia, anche a causa della mancato accordo di interconnessione con la vicina linea FS, e dei progetti dell’alto Lazio mai iniziati. Si creò quindi un consorzio formato dai comuni che la ferrovia attraversava, che prese il controllo dell’intera linea lasciando in gestione la FAI che grazie alla legge 1221/1952, riuscì ad acquistare nuovo materiale rotabile per garantire i servizi necessari.
La scelta del materiale rotabile, puntò sulla trazione termica anziché elettrica, in quanto ripristinare la trazione in alternata era molto difficile, a causa dei danneggiamenti bellici (sottostazioni distrutte, palificazione totalmente devastata). La scelta del materiale rotabile ricadde su automotrici tipo Aln 668; Aln 772; il noleggio di vecchie Aln 56 e 556; negli anni a seguire si cercò materiale usato anche all'estero, specialmente in Germania e qualcosa in Francia.
Sul finire degli anni cinquanta, anche la Veneta investì nel processo di sostituzione della trazione a vapore su quelle linee sociali che nello stesso periodo non venivano chiuse, utilizzando le risorse fornite dallo Stato sempre con la legge 1221/1952. Si procedette all'acquisto di locomotori diesel, alcuni reperiti sul mercato dell'usato, altri frutto di progetti nuovi, come il gruppo di locomotive DE.424, fatte costruire alla Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB). Furono introdotte le automotrici gruppo ADn 800 e furono acquistate due unità simili alla serie 1400 delle 688 FS che furono immatricolte nel gruppo ADn 600.
La politica delle soppressioni, tuttavia, proseguì anche negli anni sessanta. Nel 1964, terminarono le attività sulla Budrio–Massalombarda, sulla Thiene–Rocchette e sulla Rocchette-Arsiero. Nel 1968 fu chiusa definitivamente la Carnia–Villa Santina, dopo che già nel 1960 ne era stato soppresso il servizio passeggeri.
continua...
-
aleroma
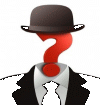
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
Dopo il 1968, la Società Veneta mantenne quindi l'esercizio ferroviario su quattro linee: la Adria–Mestre, la Bologna–Portomaggiore, la Parma–Suzzara e la Udine–Cividale.
Nel luglio 1969 fu istituita la Società Veneta Autoferrovie (SVA): un'impresa controllata dalla SV che ebbe il compito di rilevare dalla capogruppo tutte le concessioni ferroviarie e automobilistiche. Con Decreto ministeriale 29 dicembre 1970, n. 2192, il Governo italiano approvò il passaggio di consegne, ad eccezione della Parma–Suzzara che rimase in capo alla Veneta: il consorzio intercomunale, che ne possedeva la concessione originaria, si era infatti opposto al trasferimento della subconcessione. La Veneta, tuttavia, fece gestire la linea dalla SVA tramite mandato institutorio.
Il 3 luglio 1977 la società, divenuta una finanziaria, ripristinò l'originaria ragione sociale ovverosia Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche.
Nel 1981 avvenne un altro stravolgimento della composizione del gruppo societario. La SVA cedette quasi tutti i suoi rami d'azienda ad imprese a loro volta controllate dalla Veneta: gli esercizi della Bologna–Portomaggiore e delle autolinee del bolognese passarono alla Cooperativa Trasporti Romagnoli (TraRo), mentre quelli della Adria–Mestre e della Udine–Cividale andarono alla Ferrovie del Nord Est (FNE). Furono istituite anche la Autolinee Patavine (AUPA) e le Autolinee Ferraresi (AUFE). La SVA mantenne l'esercizio della Parma–Suzzara per nome e conto della Società capogruppo.
Il 6 febbraio 1986, il Ministero dei Trasporti decretò la gestione commissariale per le quattro linee ferroviarie del gruppo della Veneta di fatto concludendo l'operatività della SVA. Dal punto di vista degli autoservizi, le linee ex AUPA passarono in parte alla provincia di Padova e in parte al Consorzio Trasporti Veneziano; le linee ex Tra.Ro invece furono in gran parte riscattate dallo Stato l'11 novembre 1986, passando alla gestione commissariale governativa Ferrovia Bologna-Portomaggiore ed Autoservizi (le restanti confluirono nell'ATC di Bologna il 1º gennaio 1987).
Nel 1967, l’ormai indipendente FAI, iniziò il processo di elettrificazione a corrente continua 3000V, in conformità con gli impianti FS per l’intera linea Borgonaccio terme – Montemomi, (tranne la diramazione per Valcigo) e acquistò materiale rotabile adatto alla nuova trazione.
Oltre al materiale ordinario, loco, carrozze, la FAI acquistò alcune elettromotrici che come in altre realtà “concesse ” furono utilizzate, (molto in ritardo rispetto ad altre ferrovie vedi ad esempio la FVC Casalecchio –Vignola nel 1938/40 e le FNM nel 1936 con i Tolloni), quelle a cassa di acciaio inox tipo “Budd” costruite dalla Piaggio.
Mentre tutto il materiale diesel passò, sulla tratta Spillo di S’Anna – Valcigo, di fatto potenziata, che rimase a trazione termica ancora per qualche anno.
continua...
-
aleroma
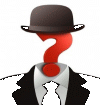
- Messaggi: 123
- Iscritto il: lunedì 29 ottobre 2018, 17:45
- Nome: alessio
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Civita di Borgonaccio e la sua ferrovia
in questo caso ho scelto di modificare un modello francese (nella foto si vedono ancora gli stemmi e le scritte originali) comprato un po' di tempo fa, è un modello statico che si acquistava dal giornalaio in Francia, facile da modificare e renderlo motorizzato.
buona serata a tutti
alessio